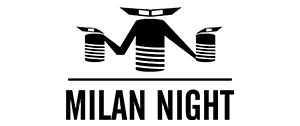Leonardo Nascimento de Araújo e Gennaro Gattuso. Il dirigente e l’allenatore. Al termine di una figuraccia come quella rimediata ad Atene dal nostro amatissimo Milan, condizionata certamente anche da un arbitraggio che definire non all’altezza è eufemistico, ci si sarebbe potuti aspettare più o meno velate critiche al tecnico e alla squadra da parte della società e, al contrario, un attacco frontale al direttore di gara da parte dell’allenatore. Invece è andata esattamente all’opposto. Leonardo ha messo subito le mani avanti parlando di «squadra in costruzione» di «eliminazione ingiusta» arrivando addirittura a prendersela con l’arcinoto casino d’ordinanza prodotto dalle bolge degli stadi greci, dove è arcinoto che si suonino più clacson che durante un ingorgo in tangenziale alle 7 di sera. «Il regolamento non lo permette», ha chiosato l’ex fantasista, manco fosse una buona ragione per non tirare in porta. Gattuso invece no. Lui, che il didietro lo rischiava e lo rischia ogni partita, non ha accampato scuse. Ha ammesso che «è giusto così». Che è giusto che il Milan se ne torni a casa con le pive nel sacco. A testa bassa. Non solo. Si è detto «incazzato nero» e ha ammesso candidamente un problema, che forse nemmeno lui sa come risolvere fino in fondo: «Alla prima difficoltà crolliamo». Amen.
Leonardo Nascimento de Araújo e Gennaro Gattuso. Il dirigente e l’allenatore. Al termine di una figuraccia come quella rimediata ad Atene dal nostro amatissimo Milan, condizionata certamente anche da un arbitraggio che definire non all’altezza è eufemistico, ci si sarebbe potuti aspettare più o meno velate critiche al tecnico e alla squadra da parte della società e, al contrario, un attacco frontale al direttore di gara da parte dell’allenatore. Invece è andata esattamente all’opposto. Leonardo ha messo subito le mani avanti parlando di «squadra in costruzione» di «eliminazione ingiusta» arrivando addirittura a prendersela con l’arcinoto casino d’ordinanza prodotto dalle bolge degli stadi greci, dove è arcinoto che si suonino più clacson che durante un ingorgo in tangenziale alle 7 di sera. «Il regolamento non lo permette», ha chiosato l’ex fantasista, manco fosse una buona ragione per non tirare in porta. Gattuso invece no. Lui, che il didietro lo rischiava e lo rischia ogni partita, non ha accampato scuse. Ha ammesso che «è giusto così». Che è giusto che il Milan se ne torni a casa con le pive nel sacco. A testa bassa. Non solo. Si è detto «incazzato nero» e ha ammesso candidamente un problema, che forse nemmeno lui sa come risolvere fino in fondo: «Alla prima difficoltà crolliamo». Amen.
Questo parallelismo mi ha fatto tornare alla mente una lezione di leadership e team building che avevo seguito anni fa. Relatore d’eccezione, Julio Velasco, storico allenatore della nazionale italiana di volley (oggi a Modena). Velasco aveva raccontato un aspetto della sua esperienza nel volley per denunciare quella che lui stesso riteneva fosse il più grande discrimine che distingue i perdenti dai vincenti. Nello sport, ma anche nel lavoro e nella vita: la cultura degli alibi. Spiegava Velasco, riferendosi, ovviamente, al suo sport: «Gli schiacciatori attribuiscono sempre i loro errori a un’alzata non corretta. E se la prendono con gli alzatori, chiedendo palle più alte, precise e vicine alla rete. A loro volta gli alzatori non ci stanno e sostengono che se l’alzata non è stata perfetta è perché i ricevitori non hanno ricevuto bene, costringendoli a un movimento innaturale. Il problema è che poi ricevitori, siccome non possono accusare l’avversario di turno di aver battuto bene e di non essere riusciti a ricevere come si dovrebbe, si guardano tra loro e, il più delle volte, sostengono di aver ricevuto male perché disturbati da un faretto male installato, sulla copertura del palazzetto. In sostanza quando perdiamo – aveva concluso l’argentino con sarcasmo – spesso è per colpa degli elettricisti». Ecco perché il tecnico campione del mondo aveva imposto come regola agli schiacciatori di non parlare mai delle alzate: «Io voglio avere in squadra – aveva spiegato – schiacciatori capaci di schiacciare palle alzate male. In grado di risolvere la schiacciata. Perché uno che riesce a gestire con successo una palla alzata male, sicuramente schiaccerà meglio di tutti gli altri i palloni alzati bene». L’efficace metafora di Velasco ci fa tornare al tema della cultura degli alibi. Leonardo pare esserne vittima. Come la stragrande maggioranza delle persone, noi stessi nei nostri rispettivi ambiti probabilmente compresi. Se falliamo non è perché abbiamo sbagliato. E’ «colpa» di qualcosa o di qualcuno che sfugge al nostro controllo.
Perché questa digressione? Semplicemente per far notare che Gattuso è diverso dal 98,7% di tutti noi. Lui non cerca alibi. E dice (almeno così pare) quel che pensa. Rinuzzo non ha cercato alibi anche se, volendo, ce ne sarebbe stato uno grosso come il grattacielo di Varsavia: l’arbitro. E questo non è un dettaglio. E’ segno che – al di là dei limiti tecnici che il buon Gennarino può avere o meno, la mentalità è quella corretta. Quella, come spiegava Velasco, che deve avere un leader. Che di fronte a una difficoltà non può rifugiarsi negli alibi o scaricare la colpa su qualcun altro. Ma deve fare solo una cosa: trovare soluzioni. Soluzioni che, in questo Milan, non possono non passare dal recupero di una serenità interrotta, di fatto, dopo la sconfitta contro la Juventus, dopo i presunti mal di pancia del suo giocatore più remunerato e rappresentativo, dopo la consapevolezza che l’Ad dal nome esotico e che piace perché «ah… la Premier…» non ha fatto altro che riproporre ricette simili a quelle di un passato ancora troppo recente e, forse, ancora troppo poco distante. Il Milan dei giovani, il Milan del vivaio, il Milan che cammina con le proprie gambe, lo stadio nuovo… Cosette che ricordano vagamente il modello Arsenal, che sta simpatico quasi a tutti forse proprio perché non vince quasi mai una beata. Ora, dopo una sentenza Uefa dura ma non durissimissima, occorre, per la squadra, ritrovare la serenità per vincere la prossima (a mani basse, mi raccomando, eh) e, per la società, produrre un piccolo sforzo per rinforzare l’unico reparto in cui siamo davvero contati sulle dita di una mano monca: il centrocampo. Un acquisto soltanto, altro non chiedo. Però scelto bene, eh. Ma bene bene. Sarebbe più che sufficiente, dopo l’arrivo di un Paqueta che, scopriamo oggi dalle parole di Nelson Dida, avrebbe tutte le caratteristiche per giostrare con successo da seconda punta o da «falso nove». Se poi dovesse arrivare qualche buon rincalzo, ben venga. Ma il centrocampista deve essere buono buono. Perché a gennaio le squadre non si possono cambiare. Ma rinforzare sì. E adesso che ci siamo – nostro malgrado – liberati dell’impiccio della Europa League occorre ancora di più puntare alla zona Champions. Che è la coppa che conta davvero. Quella che porta i soldi grossi. E che quindi, se raggiunta, può garantire quegli introiti fondamentali per realizzare il progetto del Milan del futuro. Questa la sostanza da qui a giugno. Tutto il resto, ad oggi, è contorno.
Marco Traverso






![Roma Milan 2 1 Europa League Highlights e interviste post gara [link video]](https://i0.wp.com/www.milannight.com/v2/wp-content/uploads/2024/04/post-roma-EL.jpg?resize=218%2C150&ssl=1)

![Sassuolo Milan 3 3 Highlights, interviste e conferenza post gara [link video]](https://i0.wp.com/www.milannight.com/v2/wp-content/uploads/2024/04/offside-sassuolo.jpeg?resize=218%2C150&ssl=1)
![Milan Roma 0 1 Highlights e interviste post gara [link video]](https://i0.wp.com/www.milannight.com/v2/wp-content/uploads/2024/04/milan-roma-EL.png?resize=218%2C150&ssl=1)